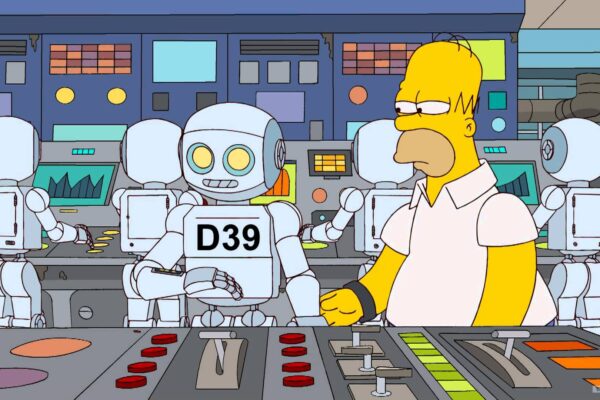Il tema del lavoro domestico è emerso in tutta la sua importanza nel corso di questa pandemia: la paura del contagio e le difficoltà nella gestione di tempi di vita e di lavoro a causa di home working e chiusura delle scuole ci hanno messo davanti alla necessità di vedere e riconoscere l’importanza di quel lavoro che troppe volte viene dato per scontato. Come ricorda la stessa Convenzione ILO 189/2011 sul lavoro domestico, con questo termine si intende qualsiasi lavoro svolto in casa o per la casa; la dimensione spaziale è dunque essenziale (Marchetti, 2011) e ingloba tanto attività di cura diretta come l’assistenza ad anziani e bambini, quanto attività di cura indiretta come la cura della casa. È lo spazio domestico che determina il carattere di atipicità del settore e che rende difficile la sua regolamentazione (ILO, 2013;2016); ed è proprio lo spazio domestico ad aver rivestito un ruolo privilegiato nell’ultimo anno, esplicitando tutte le contraddizioni che lo attraversano.
Partendo dalla spiegazione del carattere di invisibilità costitutiva che determina organizzazione e svolgimento del lavoro domestico, il presente articolo si concentra in prima battuta sulla definizione dell’invisibilità di questo lavoro a partire dall’interazione di diverse sfere di azione sociale, per definire i processi sociali, economici e culturali che contribuiscono a sminuire il valore economico e sociale della cura. È poi inevitabile sottolineare il continuum concettuale esistente tra lavoro domestico gratuito e retribuito, che svaluta il secondo come conseguenza della storica svalutazione e del mancato riconoscimento del primo. Nel fare ciò, analizzare l’impatto della pandemia da Covid-19 sul lavoro domestico retribuito comporta necessariamente considerare anche l’impatto complessivo della pandemia sulla forza-lavoro femminile. Un simile approccio permette di capire perché le attività legate alla riproduzione sociale della vita stessa siano considerate un onere privato e individuale all’interno di un sistema di welfare basato sul familismo (Esping-Andersen, 1990; Bettio, Simonazzi, Villa; 2006).
Infine, procederò con la descrizione dell’impatto che l’attuale situazione pandemica ha avuto e ha sul lavoro domestico esternalizzato, ovvero svolto da lavoratrici[1] domestiche a pagamento, per poi esplicitare tutti i limiti derivanti dal considerare le responsabilità di cura come onere privato e femminile. Per farlo, farò affidamento su dati statistici già disponibili, recenti studi e interviste svolte nell’ambito della mia ricerca di dottorato, che ha necessariamente dovuto tener conto anche del «fattore Covid». Se la pandemia ha, infatti, dimostrato la nostra interdipendenza e reciproca connessione, occorre ora un cambio di paradigma che consenta di riconcettualizzare il care burden come onere collettivo, verso la costruzione di quella che Joan Tronto definisce democrazia della cura e che appare oggi più che mai come un passaggio necessario per l’elaborazione e la costruzione di relazioni sociali e politiche più democratiche.
Domestic work is work
Secondo i più recenti dati ISTAT, il tasso di irregolarità nel settore Ateco T (attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro domestico), nel 2019 era pari al 57,6%: un numero elevatissimo che conferma l’esistenza di quell’«attributo speciale del lavoro domestico» (Triandafyllidou, 2013) identificabile nella condizione di invisibilità che caratterizza le lavoratrici domestiche (le donne rappresentano infatti l’88,7% del totale nel 2019 secondo gli ultimi dati INPS). Tale condizione è sicuramente legata alla dimensione intima e privata del luogo in cui questo specifico rapporto di lavoro si costituisce, ma non bisogna trascurare l’importanza del campo simbolico e culturale nella definizione del lavoro domestico come non-lavoro (Lutz, 2017; Federici, 2010). Per chiarire questo punto occorre fare riferimento ai diversi regimi che strutturano l’organizzazione di questo settore lavorativo sui generis, e che afferiscono all’ insieme di norme, codici socioculturali e corrispondenti pratiche che strutturano specifiche forme di organizzazione sociale (Esping-Andersen,1990).
Innanzitutto, occorre ribadire la natura familistica del regime di welfare italiano: come gran parte dei paesi con un regime di welfare mediterraneo (Ferrera, 1996), esso trova nella famiglia la sua unità principale in termini di protezione sociale, e si basa sull’erogazione di sussidi economici più che sull’implementazione di servizi pubblici. Una simile organizzazione si inserisce in un contesto segnato dalla rigida demarcazione e simultanea sessualizzazione tra sfera pubblica e sfera privata: se la prima, declinata sulla base di attributi maschili quali indipendenza e autonomia, riguarda la dimensione produttiva dell’organizzazione socioeconomica, la seconda investe il campo della riproduzione della vita stessa, delle emozioni e della cura, ed è definita come sfera essenzialmente femminile.
Fino a quando la casa era in sé tanto luogo di riproduzione e consumo, quanto luogo di produzione, infatti, non si assisteva a quella rigida divisione sessuale del lavoro che si accompagna allo sviluppo del Capitalismo industriale (Federici, 2010; Fraser, 2016) e che identifica nel solo lavoro economicamente produttivo il «vero lavoro», considerando il lavoro domestico e di cura come una vocazione femminile. Il genere, inteso come categoria di analisi storica per valutare le asimmetrie di potere attribuite alle differenze di sesso (Scott, 1986), appare essenziale nella spiegazione dello storico processo di invisibilizzazione e svalutazione del lavoro domestico. A partire dagli anni Settanta, questa pretesa vocazione universalmente femminile è stata criticata e decostruita dai femminismi, evidenziando il vantaggio tutto economico del far svolgere attività essenziali al mantenimento della società stessa alle donne in forma gratuita[2], e arrivando poi all’elaborazione di quella teoria della riproduzione sociale che riporta in luce i legami esistenti tra dimensione produttiva e riproduttiva, da intendere all’interno di un sistema integrato in cui la prima non potrebbe funzionare senza la seconda (Fraser 2016, Bhattacharya, 2018). Appare così più chiaro anche il funzionamento di un sistema di welfare familistico come il nostro, che inevitabilmente riproduce le asimmetrie di genere storicamente sedimentate. A partire dal secondo dopoguerra, però, si è assistito a una crescente partecipazione femminile al mondo del lavoro, definita come femminilizzazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del lavoro (sebbene occorra tenere presente che le donne, specialmente quelle dei ceti più poveri, hanno sempre lavorato, pur venendo classificate anche a livello statistico come casalinghe (Sarti, Bellavitis, Martini, 2018).
Anche il regime organizzativo del mondo del lavoro emerge nella sua importanza: l’ingresso della forza lavoro femminile ha riguardato essenzialmente settori femminilizzati, basati sulla messa a valore di caratteristiche tipicamente femminili quali attenzione, disponibilità e cura, come dimostrato dalle altissime percentuali di donne insegnanti, infermiere, e addette all’economia dei servizi in generale. D’altra parte, l’incremento numerico ha posto i primi problemi circa la capacità di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, secondo un’idea di conciliazione che si declina esclusivamente al femminile. Quello che emerge è che, in mancanza di servizi adeguati e accessibili, le incombenze relative al lavoro domestico hanno costituito e costituiscono tutt’ora un limite notevole all’effettiva partecipazione delle donne al mercato del lavoro, da sempre ritenuta secondaria e subalterna rispetto a quella maschile: basti pensare alle altissime percentuali di donne che lavorano in regime di part-time e con contratti atipici (INAPP, 2020; Maestripieri, Insarauto, 2020).
Negli anni, l’incremento dei flussi migratori si è rivelato, però, una soluzione di emergenza che ha visto le famiglie italiane ricorrere a forza lavoro migrante da impiegare nel lavoro domestico, anche a causa del generale invecchiamento della popolazione che caratterizza l’Italia da qualche decennio, arrivando alla definizione del cosiddetto “migrant-in-the-family model of care” (Bettio, Simonazzi, Villa, 2006). Il regime migratorio, inteso come l’insieme di politiche migratorie, norme su cittadinanza e residenza e norme culturali che regolano l’interazione con le minoranze etniche (Williams, 2012), aiuta a definire il quadro, data l’elevata percentuale di lavoratori migranti. In questo caso, all’invisibilità de facto che caratterizza questo specifico settore lavorativo, si aggiunge anche l’invisibilità de jure derivante dal difficile e tortuoso iter di regolarizzazione dei migranti in Italia: le specifiche politiche migratorie e la produzione giuridica di soggettività diverse creano, infatti, diversi modelli di lavoratori, aventi accesso diverso tanto al mondo del lavoro, quanto al sistema di protezione sociale (Mezzadra, Neilson, 2014; Chignola, Sacchetto, 2017). L’invisibilità costitutiva del lavoro domestico appare dunque un tratto essenziale, determinato dall’interazione tra i tre diversi regimi economico-sociali fino a qui esposti. È in questo contesto che vanno inquadrati tanto l’effetto diretto della pandemia da Covid-19 sul settore, quanto le risposte previste a livello giuridico e normativo per fronteggiare l’emergenza.
Lavoratrici e madri multitasking
Per evidenziare gli effetti della pandemia sul settore del lavoro domestico occorre valutare il più ampio impatto avutosi sull’occupazione femminile e sulle necessità di cura familiare. Bisogna tenere in considerazione che questa crisi ha colpito in particolare i settori più femminilizzati dell’economia, ovvero quelli della sfera dei servizi (Alon et al., 2020), mentre il blocco dei licenziamenti non è servito a tutelare chi lavora con contratti atipici, soprattutto donne, migranti e giovani: secondo l’ISTAT, dei 444mila occupati in meno registrati in tutto il 2020, ben il 70% sono donne. I dati sull’inattività femminile sono poi ancora più allarmanti, se si considera che il tasso di inattività femminile (15-64 anni) nel quarto trimestre del 2020 è stato pari al 44,8%, mentre quello maschile pari al 25,9%. Il ricorso al lavoro da casa non ha esonerato le donne dalle loro responsabilità domestiche, specialmente se si considera la prolungata chiusura delle scuole: secondo uno studio INAPP (2020), durante il periodo di lavoro da casa, il 53% delle donne ha affermato che l’impegno lavorativo è aumentato e, secondo il 30% di esse, ciò è stato dovuto essenzialmente alla cura dei figli; mentre tra il 43% di uomini che hanno percepito come aumentato il carico di lavoro, nessuno fa riferimento alle incombenze relative alla cura dei figli.
La stessa spartizione delle responsabilità domestiche nei mesi di lockdown ha confermato la tradizionale divisione sessuale del lavoro: secondo un recente studio (Del Boca et al., 2020), il 61% delle donne intervistate ha dichiarato di aver dedicato più tempo di prima alla cura dei figli, a fronte del 51% di intervistati uomini; se si considera però la cura della casa, la percentuale di donne che vi hanno dedicato più tempo di prima arriva al 68%, mentre per gli uomini si attesta sul 40%. Il passaggio alla fase di riapertura non ha visto sostanziali cambiamenti rispetto alla divisione degli oneri di cura all’interno delle famiglie: in generale, le donne si sono dimostrate più disponibili a tardare il rientro al lavoro fuori casa per assolvere alle necessità di cura e assistenza in casa. Secondo l’INAPP:
Come è evidente, e in linea con l’incidenza di genere del carico assistenziale, le tematiche legate alla gestione familiare (utilizzo del congedo parentale o esclusione subita con motivazione familiare) sono pratiche rivolte a lavoratrici prettamente femminili. Va inoltre notato che gli appelli a “incoraggiare le dimissioni volontarie” sono stati rivolti esclusivamente alle donne. (INAPP, 2020)
I dati concernenti l’Italia sembrano riflettere, dunque, una tendenza diffusa in tutto il mondo in epoca pandemica, come sottolineato dalle stesse Nazioni Unite (2020), ovvero un aumento del carico della cura per le donne, che non emerge come una novità, bensì come una conferma della condizione di svantaggio strutturale che interessa la componente femminile della popolazione. È interessante notare che, in una simile situazione, nei contesti in cui, in nome di una pretesa neutralità, si rifiuta l’implementazione di politiche in linea col l’approccio del gender mainstreaming (approccio consistente nel garantire una prospettiva di genere in senso trasversale), si hanno spesso effetti opposti a quelli sperati (Nazioni Unite, 2020; INAPP, 2020). D’altra parte, le stesse misure adottate in via prioritaria o esclusiva per le donne rischiano di rinforzare ruoli e stereotipi di genere già esistenti e spesso legati al care burden, aggravando ulteriormente la condizione delle donne nel mercato del lavoro: pensiamo alle misure di conciliazione indirizzate in via prioritaria alle donne, o al ricorso a contratti part-time specialmente per le lavoratrici tra le quali si registra, tuttavia, ben il 55,7% di forme di part-time involontario che sembrano rispondere più alle esigenze di flessibilità delle aziende che a quelle di conciliazione delle lavoratrici (Maestripieri e Insarauto, 2020).
Sintetizzando, partirò dalla considerazione che, nonostante l’imprevedibilità della fase attuale, quello a cui stiamo assistendo nel mercato del lavoro femminile e femminilizzato ha radici profonde. Attenendoci al mondo del lavoro direttamente produttivo, sta chiaramente emergendo l’elevata frammentazione del nostro mercato del lavoro, che vede le donne interessate da fenomeni di segregazione sia orizzontale che verticale (INAPP, 2020). A questo va aggiunta poi la crescente eterogeneità a livello contrattuale, che vede una moltiplicazione costante di contratti atipici soprattutto tra donne, migranti e giovani, che aggravano ulteriormente il quadro complessivo se si considerano, per esempio, le ripercussioni in termini di protezione sociale. In tal senso, occorre tenere conto anche del peso notevole esercitato nel nostro paese dal lavoro nero e dalle diverse forme di lavoro grigio che affliggono ancora il mercato del lavoro con un’incidenza specifica in determinati territori. Se questo è il quadro complessivo, gli ultimi mesi hanno esplicitato chiaramente il limite principale che occorre superare: il care burden interessa soprattutto le donne e viene aggravato dall’assenza di servizi di cura, come evidenziato anche dalla maggiore tendenza all’inattività femminile registrata a Sud in concomitanza con una minore presenza di servizi sul territorio (Maestripieri e Insarauto, 2020). Nei mesi scorsi le famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con le necessità della riproduzione sociale, e si è notato specialmente quanto l’assenza di protagonismo da parte dello Stato nell’assunzione di responsabilità di cura abbia un impatto diretto sulle condizioni lavorative delle donne: la cura come responsabilità individuale e strettamente femminile ha mostrato i suoi limiti, e l’analisi delle condizioni di lavoro e vita di lavoratrici domestiche in pandemia ne è un’ulteriore conferma.
Lavoratrici essenziali, ma invisibili
Per approfondire in che modo il settore del lavoro domestico sia stato interessato da questi mesi di pandemia si può partire da alcune considerazioni dell’ILO (2020): la paura del contagio e le restrizioni alla mobilità individuale adottate in diversi Stati hanno avuto un impatto notevole sulle lavoratrici domestiche in termini di perdita del lavoro e riduzione delle ore lavorate. Ovviamente, la situazione è più drammatica nei Paesi che registrano un’elevata percentuale di lavoratrici informali (una tendenza che comunque caratterizza il lavoro domestico in diversi contesti a causa della sua natura di rapporto di lavoro sui generis): la proporzione di lavoratrici domestiche significativamente colpite dall’epidemia di Covid-19 in Europa passa dal 36,6% del 15 marzo 2020 al 50,1% del 15 aprile 2020 (ILO, 2020). Inoltre, il sussidio di disoccupazione non viene sempre garantito neppure alla componente regolare di lavoratrici del settore: il rischio di rimanere senza fonti di reddito ha interessato soprattutto lavoratrici non conviventi, ma la scarsa formalizzazione del settore e la consapevolezza spesso mancante tra le famiglie datrici di lavoro hanno privato della propria stabilità economica anche molte lavoratrici conviventi, con gravi conseguenze anche per le famiglie residenti nel paese d’origine che spesso sopravvivono grazie alla rimesse inviate dall’Italia.
A livello europeo, l’obiettivo di molti governi è stato proteggere il reddito delle lavoratrici domestiche tramite misure di protezione sociale e blocco dei licenziamenti, come esplicitato da Gianni Rosas (2020). Sintetizzando, il Belgio ha esteso durata della copertura e anche categorie di lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, hanno dovuto sospenderlo per cause di forza maggiore, prevedendo un’indennità di disoccupazione pari al 70% della retribuzione elargita tramite voucher, e con copertura statale totale dei contributi previdenziali. La Francia ha previsto la corresponsione dell’80% dello stipendio per i periodi di lavoro non lavorati, che viene anticipata dal datore di lavoro (includendo anche individui e famiglie datrici di lavoro domestico) e successivamente rimborsata dallo Stato, includendo la totalità dei contributi previdenziali. In Germania è stata prevista una compensazione a breve termine, simile alla cassa integrazione guadagni italiana e corrispondente al 60% della retribuzione, con un incremento del 7% per lavoratori con figli a carico. La Spagna, infine, pur non avendo ratificato la Convenzione ILO 189/2011 sul lavoro domestico, ha esteso alle lavoratrici regolari l’accesso a un’indennità di disoccupazione pari al 70% della retribuzione.
L’Italia, pur avendo ratificato la Convenzione ILO 189/2011 sul lavoro domestico, il cui perno appare essere il principio di uguale trattamento delle lavoratrici attive nel settore, ha visto misure di sostegno tardive e incoerenti. L’elevata componente di lavoro irregolare ha ovviamente aggravato l’impatto della pandemia sul settore, mentre l’elevata percentuale di anziani sul totale della popolazione italiana e l’implementazione negli anni di un sistema di cura definito “migrant-in-the-family” hanno esposto in maniera particolare le lavoratrici anche a rischi di salute. Se appena dichiarato il lockdown si è registrato un incremento delle regolarizzazioni del 60% rispetto a marzo 2019 (Domina, 2020) dovuto alla paura dei controlli sugli spostamenti personali, nondimeno moltissime lavoratrici, specialmente informali, si sono ritrovate da un giorno all’altro senza lavoro o, se conviventi, chiuse in casa con enormi difficoltà a definire tempi di lavoro e tempi di riposo.
A livello di azioni governative occorre sottolineare la tardività degli interventi: il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 ha riconosciuto per primo questo lavoro come essenziale, ma lo ha escluso dalle forme di sostegno al reddito e persino dal blocco dei licenziamenti, contravvenendo di fatto al principio di equivalenza sancito dalla Convenzione ILO 189/2011. Solo a seguito di una certa mobilitazione di associazioni datoriali e sindacali, ma anche dalla stessa opinione pubblica (Alemani, et al., 2020) è iniziato un iter che ha portato all’adozione di misure meno discriminatorie nel “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020.
Nel complesso, alcune misure generali potevano applicarsi teoricamente[3] anche alle lavoratrici domestiche: l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale se non è possibile mantenere il distanziamento, il riconoscimento come malattia professionale, dunque pagata dall’INAIL, se il virus da Covid-19 è stato contratto sul luogo di lavoro, il congedo di malattia durante il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dell’assistito, indennità di sostegno al reddito attraverso il fondo di ultima istanza, il ricorso a 15 giorni di congedo retribuito (50%) per lavoratrici con figli minori di 12 anni, o in alternativa un bonus baby sitter da 600 euro; bonus non tassabile di 100 euro per lavoratori con reddito annuo fino a 40 000 euro che hanno lavorato a marzo; sospensione del versamento di contributi previdenziali e assistenziali; sospensione del pagamento delle rate del mutuo per la prima casa (Domina,2020). Solo il decreto “Rilancio” ha previsto un’indennità specifica di 500 euro per i mesi di aprile e maggio per le lavoratrici domestiche non conviventi e titolari di uno o più contratti di lavoro non eccedenti complessivamente le 10 ore settimanali. La tardività nell’adozione di simili misure ha messo in chiaro, ancora una volta, la diffusa invisibilità del settore, seppure lo stesso fosse stato riconosciuto essenziale dall’inizio della pandemia. Inoltre, l’elevatissima percentuale di irregolarità ha tagliato fuori di fatto la grandissima fetta di lavoratrici conviventi che, perdendo il lavoro, spesso hanno perso anche vitto e alloggio. D’altra parte, nonostante l’adozione di una nuova misura straordinaria di emersione su cui non mi focalizzerò ora[4], bisogna sottolineare che le tante contraddizioni emerse già durante il primo lockdown e riguardanti per esempio il tema del permesso di malattia (che nel lavoro domestico viene pagato dal datore e non dall’INPS) e della maternità (durata del divieto di licenziamento che non arriva a coprire il compimento del primo anno di età del figlio), non sono state tenute in considerazione neppure in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico a ottobre 2020.
La sensazione di abbandono emerge anche dalle testimonianze di alcune lavoratrici intervistate nell’ambito della mia ricerca di dottorato[5] tra febbraio 2020 e febbraio 2021, tutte attive nell’area di Milano. Il campione di riferimento comprende dieci tra lavoratrici e lavoratori, selezionati tenendo conto di fattori quali l’età, il genere, la nazionalità, lo status giuridico (regolari o meno). Le interviste sono state pensate in forma semi-strutturata, così da garantire un riferimento costante al background teorico, ma senza limitare le risposte degli intervistati. Le interviste sono state in seguito codificate col software NVivo e analizzate tramite directed-content analysis (Hsieh e Shannon, 2005) che, facendo affidamento tanto su codes elaborati in base alla teoria di riferimento quanto su codes che emergono direttamente dalle interviste, consente un approccio più ricco e complesso al testo in analisi. A partire da qui, la differenza sostanziale rispetto a come la pandemia sia stata vissuta si struttura su due assi: essere regolari o meno, lavorare da conviventi o meno. Per quanto riguarda il primo punto, la regolarità del contratto ha rappresentato la condizione essenziale per avere accesso ai sussidi previsti, mentre per tutte le irregolari la situazione è stata particolarmente disperata:
Io parlo per me: si (ho ricevuto il bonus), però altre persone che ho visto no… sono disperate… alcune sono state mandate via prima del blocco… chiuso il contratto… hanno bloccato e chiuso il contratto prima della quarantena… poi quelle in nero niente proprio…
Le lavoratrici in regime di convivenza sono state in genere più tutelate rispetto alle colleghe non conviventi, anche se il non perdere il lavoro ha significato in tutti questi casi la reclusione totale in casa, in un contesto intimo in cui anche il rispetto di riposo e straordinari è difficilmente assicurabile. Tutto è dipeso dalla specifica relazione che queste lavoratrici avevano con la famiglia: c’è chi ha lavorato gratuitamente anche durante le ore previste per il risposo e chi invece, pur lavorando di più, ha ottenuto il pagamento degli straordinari che tuttavia non tutela dall’incremento di stress lavorativo.
Le lavoratrici, specialmente quelle che hanno perso il lavoro a causa del Covid, hanno mediamente un’opinione negativa della gestione dell’emergenza:
– Tu pensi che la tua categoria sia stata tutelata durante la pandemia?
– No perché come me ci sono tante senza contratto che… cosa fanno? Quello è un problema importante, ci sono tante persone senza lavoro e adesso non hanno nessuna tutela… e poi come cambierà dopo… sarà difficile la questione della sicurezza perché devi portare un’estranea a casa e non sai se ha avuto qualche sintomo, qualcosa….
In una situazione complessivamente molto caotica, molte lavoratrici hanno provato ad arrangiarsi, e moltissime hanno sofferto la cattiva comunicazione che le ha spesso portate a ignorare le misure su cui potevano eventualmente fare affidamento. L’incertezza sperimentata, poi, è stata spesso un riflesso della stessa incertezza vissuta dalle famiglie, che hanno deciso spesso di interrompere il rapporto di lavoro nell’immediato:
Secondo me l’incertezza della prospettiva futura ha portato chi aveva la priorità della questione economica a dire: vabbè, vediamo poi dopo, intanto interrompiamo… è quello che è successo a me…
È interessante notare che per le lavoratrici, anche la dinamica dello smart working non ha di fatto alterato la domanda di lavoro: se è vero che molte famiglie hanno deciso di rinunciare alle assistenti familiari, secondo le lavoratrici è stato più per motivi di natura strettamente economica che non per una riduzione effettiva delle necessità di cura, cosa che ovviamente ha avuto (e ha ancora) un impatto diretto sui salari delle lavoratrici:
Adesso sicuramente tante famiglie hanno abbassato le richieste perché stanno lavorando da casa, ma nessuna mamma adesso si mette a fare la pulizia eh! Se lavorano da casa… le donne sono già abituate ad avere aiuto delle domestiche… sicuramente ti pagano meno, però la ricerca c’è. La ricerca c’è e i prezzi sono bassi, questo sì…
Il quadro che emerge dalle interviste, dunque, sembra confermare quanto riferito negli studi citati in precedenza: il lavoro domestico in pandemia ha continuato ad essere considerato invisibile e quindi poco tutelato. Soprattutto, è emersa chiaramente l’enorme contraddizione tra il riconoscimento di vivere in un mondo interdipendente e l’impostazione individualistica e privatistica della cura. Se, da un lato, questo lavoro è stato fin dall’inizio riconosciuto come essenziale, dall’altro non è stato messo in discussione il fatto che esso sia primariamente una faccenda privata e familiare. Una simile concezione delle responsabilità della riproduzione sociale lascia di fatto queste lavoratrici in balia delle domande e necessità della famiglia datrice di lavoro: la condizione vissuta riflette più la peculiare relazione personale posta in essere con la famiglia datrice, che la relazione lavorativa stabilita dal contratto di lavoro (se presente). In un simile contesto è inevitabile perdere omogeneità nel trattamento di questo settore: l’emergenza pandemica ha messo in luce la necessità di intervenire sulla componente irregolare di questo settore lavorativo che non può essere considerata una novità, ma anzi una costante che può essere modificata solo intervenendo sull’organizzazione della cura e del welfare nel suo complesso.
Conclusioni
Sintetizzando quanto esposto in precedenza, possiamo affermare che lo scoppio della pandemia ha messo in luce tutta una serie di contraddizioni della nostra organizzazione sociale, tra cui sicuramente quella della cura. Purtroppo, però, anche misure governative recenti come il Family Act del 2020, continuano a riproporre un’idea di cura come responsabilità privata, familiare e femminilizzata, e i timidi passi avanti fatti con l’estensione del congedo di paternità a 10 giorni, non sono ancora abbastanza. Occorrerebbe, forse, prendere in considerazione la necessità di quella che Joan Tronto definisce democrazia della cura (2013), ovvero una democrazia che vede nella cura uno dei suoi pilastri portanti, e che la riconosce dunque come responsabilità collettiva e politica. Questo significa contrastare quel processo di mercatizzazione e ulteriore privatizzazione del lavoro domestico e di cura di stampo marcatamente neoliberista, e che non fa che acuire le asimmetrie economiche e sociali esistenti (Marchetti e Farris, 2017). Se negli anni passati abbiamo visto l’implementazione di sistemi di trasferimenti economici alle famiglie, pur con percentuali molto più basse di quelle di altri Stati europei (DOMINA, 2020), non abbiamo invece assistito a nessun tentativo di investire davvero nel settore. Misure come la previsione di un bonus per caregivers familiari inserita nella legge di bilancio 2021, per quanto lodevoli e funzionali a svelare il valore economico e sociale del lavoro domestico, lo intendono ancora come responsabilità privata. Continuare ad affrontare il problema attraverso i trasferimenti economici non sembra una soluzione, specialmente se si considera il diverso impatto che tali misure hanno su nuclei familiari in diverse condizioni economiche (Morel, 2007).
Neppure il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur avendo come uno dei suoi obiettivi principali la riduzione della disuguaglianza di genere, riesce a uscire dalla dimensione familistica del welfare, che continua ad essere data spesso per scontata, specialmente per quanto riguarda l’assistenza ad anziani e persone non autosufficienti. In particolare, il Piano si propone di de-istituzionalizzare ulteriormente il settore delle residenze per anziani e si focalizza sull’assistenza domiciliare integrata finalizzata più a cure infermieristiche e di riabilitazione, che alla cura quotidiana degli anziani; il mondo delle assistenti domiciliari, poi, è totalmente assente (Da Roit, Ronci, 2021). In un momento come quello attuale, invece, occorrerebbe una maggiore presenza statale: si potrebbe forse osare e capire che è il caso di investire in quella che l’ILO stessa definisce care economy (2018), ovvero in servizi diretti accessibili universalmente che, oltre a sollevare le famiglie, permetterebbero di creare nuovi posti di lavoro. Un simile cambio di paradigma, inoltre, può servire a livellare non solo le disuguaglianze interne ai singoli Stati, ma anche quelle esistenti tra diversi Stati europei, come emerge dal ruolo cruciale che il regime di welfare gioca in tal senso, favorendo così il processo reale di integrazione a mostrando l’assunzione di responsabilità a livello comunitario su un tema che non può più essere minimizzato o nascosto.
Bibliografia
- Alemani C., Amorosi L., Busi B., Maioni R., Marchetti S., Sarti R., Turrini O., Vianello F.A., Zucca G., Verso una democrazia della cura, «InGenere», 2 aprile 2020.
- Alon D., Olmstead-Rumsey T., The Impact Of Covid-19 On Gender Equality, Working Paper 26947 Nber Working paper Series, National Bureau of Economic Research, Cambridge, aprile 2020.
- Bhatthacharya T., Social Reproduction Theory. Remapping Class, Recentering the Oppression, Pluto Press, Londra, 2017.
- Bettio F., Simonazzi A., Villa P., Change in care regimes and female migration: the ‘care drain’ in the Mediterranean, «Journal of European Social Policy», vol. 16, n. 3, 2006.
- Chignola S., Sacchetto D., Le reti del valore, DeriveApprodi, Roma, 2017.
- Da Roit B., Ronci M., Cura degli anziani, la riforma inizia dal Pnrr, «lavoce.info», 29 aprile 2021: https://bit.ly/3g9O2SC.
- Del Boca D., Oggero N., Profeta P., Rossi M.C., Villosio C., Prima, durante e dopo Covid-19: disuguaglianza in famiglia, «lavoce.info», 2020: https://bit.ly/3vc0cyT.
- Esping-Andersen G., The three worlds of welfare capitalism, Princeton University Press, Princeton, 1990.
- Farris S., Marchetti S., From the Commodification to the Corporatization of Care: European Perspectives and Debates, «Social Politics», vol. 24, n. 2, 2017.
- Federici S., Caliban y la bruja, Traficantes de sueños, Madrid, 2010.
- Ferrera M., Il modello sud-europeo di welfare state, «Rivista Italiana di Scienza Politica», vol. 26, n. 1, aprile 1996.
- Fraser N., Contradictions of Capital and Care, «New Left Review», n. 100, luglio-agosto 2016.
- Hsieh H.F., Shannon S.E., Three Approaches to Qualitative Content Analysis, «Qualitative Health Research», vol. 15, n. 9, novembre 2005.
- ILO, Convention n°189. Decent work for domestic workers, Ginevra, 2011.
- ILO, Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, Ginevra, 2013.
- ILO, Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics, International Labour Office Social Protection Dept., Ginevra, 2016.
- ILO, Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work, Ginevra, 2016.
- ILO, Impact of the Covid-19 crisis on loss of jobs and hours among domestic workers, «Policy Brief», 15 giugno 2020.
- INAIL, Infortuni e malattie professionali – Dossier Donne, 2021.
- INAPP, Gender Policies Report 2020, dicembre 2020.
- Lutz H., Care as a fictitious commodity: Reflections on the intersections of migration, gender and care regime, «Migration Studies», vol. 5, n. 3, 2017.
- Magnano R., Regolarizzazione degli stranieri “radicati” a rischio flop: in 6 mesi solo lo 0,71% delle domande, «Il Sole 24 ore», 4 marzo 2021: https://bit.ly/3w754Xc.
- Maestripieri L., Insarauto V., Più uguali ma non troppo. I problemi irrisolti del lavoro femminile tra fragilità territoriali e squilibri nella divisione dei ruoli familiari, Utopie/98 Lavoro, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2020,
- Marchetti S., Le ragazze di Asmara. Lavoro domestico e migrazione postcoloniale, Ediesse, Roma, 2011.
- Mezzadra S., Neilson B., Confini e frontiere, il Mulino, Bologna, 2014.
- Morel N., From Subsidiarity to ‘Free Choice’: Child- and Elder-care Policy Reforms in France, Belgium, Germany and the Netherlands, «Social Policy and Administration», vol. 41, n. 6, dicembre 2007.
- Osservatorio Nazionale DOMINA sul Lavoro Domestico, Secondo Rapporto Annuale sul Lavoro Domestico, 2020.
- Rosas G., Il lavoro domestico durante l’emergenza da Coid-19, «ILO Policy Brief», 6 aprile 2020.
- Sarti R., Bellavitis A., Martini M. (a cura di), What is work? Gender at the Crossroads of Home, Family and Business from the Early Modern Era to the Present, Berghan Books, New York, 2018
- Scott J.W., Gender: A Useful Category of Historical Analysis, «The American Historical Review», vol. 91, n. 5, dicembre 1986.
- Triandafyllidou A., Irregular Migration and Domestic Work in Europe: Who Cares?, Ashgate, Burlingtone, 2013.
- Tronto J., Caring Democracies: Markets, Equality and Justice, New York University Press, New York, 2013.
- United Nations, Policy Brief: The Impact of Covid-19 on Women, 9 aprile 2020.
- Williams F., Converging variations in migrant care work in Europe, «Journal of European Social Policy», vol. 22, n. 4, 2012.
Note
[1] Considerando l’elevatissima percentuale di lavoratrici donne attive nel settore (come esplicitato successivamente), userò sempre il femminile
[2] Si pensi alla campagna internazionale per il salario per il lavoro domestico portata avanti da Mariarosa Dalla Costa, Selma Jones e Silvia Federici a partire dal 1974.
[3] Molte di queste misure non si potevano applicare, di fatto al lavoro domestico: basti pensare al bonus non tassabile di 100 € che, non essendo la famiglia sostituto d’imposta, non prevedeva una modalità di riscossione alternativa.
[4] Secondo le associazioni promotrici della campagna “Ero Straniero”, a sei mesi dalla chiusura della procedura di emersione, in tutta Italia sono stati rilasciati solo 1480 permessi di soggiorno, ovvero lo 0,71% del totale delle domande (Magnano, 2021).
[5] La ricerca di dottorato si focalizza sul ruolo di agenzie e cooperative nell’organizzazione del lavoro domestico nella città di Milano. Le interviste si sono svolte quindi con dieci tra agenzie e cooperative, dieci tra lavoratrici e lavoratori, due associazioni nazionali di datori di lavoro domestico e dieci key actors come sindacalisti, ispettori del lavoro, funzionari dell’ILO. Ovviamente in questa sede, visto il focus specifico del paper, mi concentro soprattutto sulle interviste a lavoratrici e lavoratori.